
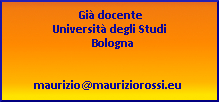
ripos
Guida alle prove scritte


ripos
Struttura delle prove scritte
Metodologia della ricerca sociale 5cfu (Mrs)
- 8 domande chiuse cap.: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, una per capitolo
- 5 domande aperte (una relativa ai Cap. 3 o 4 o 5, una al cap. 8, una al cap. 12, una al cap 13, una di commento ad una tabella).
- Durata della prova: 70 min.
Metodologie qualitative e quantitative...7cfu (Mqq)
- 8 domande chiuse (cap.: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, una per capitolo)
- 8 domande aperte ( una relativa ai Cap. 3 o 4 o 5, una al cap. 7 o 11, una al cap. 8, una al cap. 9, una al cap. 10, una al cap. 12, una al cap 13, una di commento ad una tabella).
- Durata della prova: 90 min.
Metodologia della ricerca sociale 8cfu (Mrs)
- 10 domande chiuse (2 teoria ..., 2 campionamento, 2 analisi monovariata, 4 analisi bivariata)
- 7 domande aperte (2 teoria ..., 1 campionamento, 1 monovariata, 2 bivariata e 1 di commento ad una tabella)
- Durata della prova: 90 min.
Statistica sociale
- 8 domande chiuse (2 campionamento, 2 analisi monovariata, 4 analisi bivariata)
- 5 domande aperte (4 relative ai tre argomenti - 1 o 2 campionamento, 1 o 2 monovariata, 1 o 2 bivariata - e 1 di commento ad una tabella)
- Durata della prova: 70 min.
- Per i quattro esami precedenti, nelle prove, le domande aperte e chiuse sono presentate separatamente, seguendo in entrambi i casi l'ordine dei capitoli o degli argomenti cui si riferiscono.
- Il testo delle domande che qui viene riportato coincide in linea di massima con quello utilizzato nelle prove d'esame. Le sole discordanze riguardano l'esclusione di quei termini che consentirebbero di individuarne il tipo (aperta o chiusa). L'esclusione di questi termini, tuttavia, non altera il senso delle domande. Nel caso di domande che vertono su situazioni ipotetiche presentate nella domanda stessa, la descrizione di tale situazione ipotetica viene omessa e indicata da [...]. Le tabelle che verranno utilizzate per l'ultima delle cinque domande aperte non sono riportate. Non è stata operata alcuna distinzione tra domande chiuse e aperte. Le domande vengono presentate capitolo per capitolo senza distinzione tra aperte e chiuse.
Sociologia dell'educazione
a.a. 2011-12 e precedenti:
- 5 domande aperte ( 2 testo Besozzi - 2 testo Schizzerotto-Baroni - 1 testo Dei).
- Durata della prova: 70 min.
a.a 2012-13 e seguenti:
- 5 domande aperte ( 2 testo Brint - 1 testo Dei, La scuola.. - 1 testo Dei, Ragazzi.. - 1 commento a tabella tratta da uno dei tre testi)
- Durata della prova: 70 min.
- 8 domande chiuse cap.: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, una per capitolo
- 5 domande aperte (una relativa ai Cap. 3 o 4 o 5, una al cap. 8, una al cap. 12, una al cap 13, una di commento ad una tabella).
- Durata della prova: 70 min.
Metodologie qualitative e quantitative...7cfu (Mqq)
- 8 domande chiuse (cap.: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, una per capitolo)
- 8 domande aperte ( una relativa ai Cap. 3 o 4 o 5, una al cap. 7 o 11, una al cap. 8, una al cap. 9, una al cap. 10, una al cap. 12, una al cap 13, una di commento ad una tabella).
- Durata della prova: 90 min.
Metodologia della ricerca sociale 8cfu (Mrs)
- 10 domande chiuse (2 teoria ..., 2 campionamento, 2 analisi monovariata, 4 analisi bivariata)
- 7 domande aperte (2 teoria ..., 1 campionamento, 1 monovariata, 2 bivariata e 1 di commento ad una tabella)
- Durata della prova: 90 min.
Statistica sociale
- 8 domande chiuse (2 campionamento, 2 analisi monovariata, 4 analisi bivariata)
- 5 domande aperte (4 relative ai tre argomenti - 1 o 2 campionamento, 1 o 2 monovariata, 1 o 2 bivariata - e 1 di commento ad una tabella)
- Durata della prova: 70 min.
- Per i quattro esami precedenti, nelle prove, le domande aperte e chiuse sono presentate separatamente, seguendo in entrambi i casi l'ordine dei capitoli o degli argomenti cui si riferiscono.
- Il testo delle domande che qui viene riportato coincide in linea di massima con quello utilizzato nelle prove d'esame. Le sole discordanze riguardano l'esclusione di quei termini che consentirebbero di individuarne il tipo (aperta o chiusa). L'esclusione di questi termini, tuttavia, non altera il senso delle domande. Nel caso di domande che vertono su situazioni ipotetiche presentate nella domanda stessa, la descrizione di tale situazione ipotetica viene omessa e indicata da [...]. Le tabelle che verranno utilizzate per l'ultima delle cinque domande aperte non sono riportate. Non è stata operata alcuna distinzione tra domande chiuse e aperte. Le domande vengono presentate capitolo per capitolo senza distinzione tra aperte e chiuse.
Sociologia dell'educazione
a.a. 2011-12 e precedenti:
- 5 domande aperte ( 2 testo Besozzi - 2 testo Schizzerotto-Baroni - 1 testo Dei).
- Durata della prova: 70 min.
a.a 2012-13 e seguenti:
- 5 domande aperte ( 2 testo Brint - 1 testo Dei, La scuola.. - 1 testo Dei, Ragazzi.. - 1 commento a tabella tratta da uno dei tre testi)
- Durata della prova: 70 min.
ripos
METODOLOGIA/E 5-7 cfu : Elenco domande per capitolo METODOLOGIA... 8 cfu : Elenco domande per argomento STATISTICA SOCIALE: Elenco domande per argomento SOCIOLOGIA EDUCAZIONE: Elenco domande per testoa.a 2011-12 e precedenti
SOCIOLOGIA EDUCAZIONE: Elenco domande per testo
a.a 2012-13 e seguenti
| Procedura di valutazione |
Metodologia della ricerca sociale - 5(7)cfu e
Statistica sociale
Ogni domanda chiusa produce 2 punti-esame se la risposta è corretta, 0 punti-esame se priva di risposta, -0,67 punti-esame se errata. Nelle domande che prevedono due risposte corrette, modelli di risposta parziali e/o parzialmente errati producono punti-esame intermedi tra 0 e 2 secondo il caso.
Ogni domanda aperta produce da 0 a 3 punti-esame secondo la qualità e la completezza della risposta.
Il totale dei punti-esame è nell'intervallo tra -5,3 e +31.
La conversione in trentesimi traduce in modo proporzionale l'intervallo approssimativo 6 - 24 punti-esame nell'intervallo 18 - 30. Punti-esame approssimativamente superiori a 26 producono la lode. Dopo la conversione i punteggi finali vengono lievemente modificati in aumento o diminuzione in funzione della difficoltà relativa della singola prova (in ogni appello sono distribuite 4 prove differenti) e in funzione dell'eventuale elevata incongruenza tra i risultati della parte chiusa e di quella aperta.
Metodologia della ricerca sociale - 8 cfu
Ogni domanda chiusa produce 1,5 punti-esame se la risposta è corretta, 0 punti-esame se priva di risposta, -0,5 punti-esame se errata. Nelle domande che prevedono due risposte corrette, modelli di risposta parziali e/o parzialmente errati producono punti-esame intermedi tra 0 e 1,5 secondo il caso.
Ogni domanda aperta produce da 0 a 2,3 punti-esame secondo la qualità e la completezza della risposta.
Il totale dei punti-esame è nell'intervallo tra -5 e +31,1.
La conversione in trentesimi traduce in modo proporzionale l'intervallo approssimativo 6 - 24 punti-esame nell'intervallo 18 - 30. Punti-esame approssimativamente superiori a 26 producono la lode. Dopo la conversione i punteggi finali vengono lievemente modificati in aumento o diminuzione in funzione della difficoltà relativa della singola prova (in ogni appello sono distribuite 4 prove differenti) e in funzione dell'eventuale elevata incongruenza tra i risultati della parte chiusa e di quella aperta.
Sociologia dell'educazione
Ogni domanda aperta produce da 0 a 6 punti-esame secondo la qualità e la completezza della risposta.
Il totale dei punti-esame si determina considerando le quattro migliori risposte (trascurando dunque una risposta). Il totale dei punti-esame è nell'intervallo 0-24.
La conversione in trentesimi traduce in modo proporzionale l'intervallo approssimativo 4 - 18 punti-esame nell'intervallo 18 - 30. Punti-esame approssimativamente superiori a 20 producono la lode. Prima della conversione i punti-esame vengono lievemente modificati in aumento o diminuzione in funzione della difficoltà relativa della singola prova (in ogni appello sono distribuite 4 prove differenti).
Ogni domanda chiusa produce 2 punti-esame se la risposta è corretta, 0 punti-esame se priva di risposta, -0,67 punti-esame se errata. Nelle domande che prevedono due risposte corrette, modelli di risposta parziali e/o parzialmente errati producono punti-esame intermedi tra 0 e 2 secondo il caso.
Ogni domanda aperta produce da 0 a 3 punti-esame secondo la qualità e la completezza della risposta.
Il totale dei punti-esame è nell'intervallo tra -5,3 e +31.
La conversione in trentesimi traduce in modo proporzionale l'intervallo approssimativo 6 - 24 punti-esame nell'intervallo 18 - 30. Punti-esame approssimativamente superiori a 26 producono la lode. Dopo la conversione i punteggi finali vengono lievemente modificati in aumento o diminuzione in funzione della difficoltà relativa della singola prova (in ogni appello sono distribuite 4 prove differenti) e in funzione dell'eventuale elevata incongruenza tra i risultati della parte chiusa e di quella aperta.
Metodologia della ricerca sociale - 8 cfu
Ogni domanda chiusa produce 1,5 punti-esame se la risposta è corretta, 0 punti-esame se priva di risposta, -0,5 punti-esame se errata. Nelle domande che prevedono due risposte corrette, modelli di risposta parziali e/o parzialmente errati producono punti-esame intermedi tra 0 e 1,5 secondo il caso.
Ogni domanda aperta produce da 0 a 2,3 punti-esame secondo la qualità e la completezza della risposta.
Il totale dei punti-esame è nell'intervallo tra -5 e +31,1.
La conversione in trentesimi traduce in modo proporzionale l'intervallo approssimativo 6 - 24 punti-esame nell'intervallo 18 - 30. Punti-esame approssimativamente superiori a 26 producono la lode. Dopo la conversione i punteggi finali vengono lievemente modificati in aumento o diminuzione in funzione della difficoltà relativa della singola prova (in ogni appello sono distribuite 4 prove differenti) e in funzione dell'eventuale elevata incongruenza tra i risultati della parte chiusa e di quella aperta.
Sociologia dell'educazione
Ogni domanda aperta produce da 0 a 6 punti-esame secondo la qualità e la completezza della risposta.
Il totale dei punti-esame si determina considerando le quattro migliori risposte (trascurando dunque una risposta). Il totale dei punti-esame è nell'intervallo 0-24.
La conversione in trentesimi traduce in modo proporzionale l'intervallo approssimativo 4 - 18 punti-esame nell'intervallo 18 - 30. Punti-esame approssimativamente superiori a 20 producono la lode. Prima della conversione i punti-esame vengono lievemente modificati in aumento o diminuzione in funzione della difficoltà relativa della singola prova (in ogni appello sono distribuite 4 prove differenti).
| Capitolo 1 (Paradigmi della ricerca sociale) - Corbetta | Mrs & Mqq |
| 1. A che cosa intende riferirsi Kuhn con il termine "paradigma"? |
| 2. Come si può definire il termine "paradigma"? |
| 3. Che rapporto sussiste tra "paradigma" e scienze? |
| 4. Che cosa si intende con l'espressione "questione epistemologica"? |
| 5. Che cosa si intende con l'espressione "questione ontologica"? |
| 6. Qual è la posizione dell'approccio positivista circa la natura del mondo sociale? |
| 7. Qual è la posizione del post-positivismo circa la corroborazione empirica delle teorie? |
| 8. Dove si colloca storicamente la nascita del neo-positivismo? |
| 9. Quale deve essere l'approccio alla realtà sociale secondo il paradigma interpretativo? |
| 10. Qual è la posizione dell'interpretativismo relativamente al metodo scientifico? |
| 11. Qual è la forma degli enunciati scientifici secondo l'approccio interpretativo? |
| 12. Che cos'è un "tipo ideale"? |
| Capitolo 2 (Metodi quantitativi e metodi qualitativi) - Corbetta | Mrs & Mqq |
| 1. Da quali paradigmi traggono origine i metodi quantitativi ed i metodi qualitativi? |
| 2. Che tipi di ricerche sono Crime in the making di Sampson e Laub e Islands in the street di Jankowski? |
| 3. Che rapporto c'è tra teoria e ricerca nell'indagine qualitativa? |
| 4. A quale modello logico obbedisce il rapporto teoria-ricerca nell'indagine quantitativa? |
| 5. Come si comporta il ricercatore qualitativo relativamente a teoria e concetti? |
| 6. Qual è la natura dei concetti utilizzati nelle ricerca quantitativa e qualitativa? |
| 7. Qual è la natura della relazione studioso-studiato? |
| 8. Quali tipi di generalizzazioni può fornire la ricerca qualitativa? |
| 9. Verso quali oggetti è orientata l'analisi dei dati quantitativi? |
| 10. Come devono essere i risultati nella ricerca quantitativa? |
| 11. Cosa si intende con l’espressione "prospettiva relazionale"? |
| 12. Quali sono le due forme classiche di presentazione dei dati rispettivamente nella ricerca quantitativa e qualitativa? |
| Capitolo 3 (La traduzione empirica della teoria) - Corbetta | Mrs & Mqq |
| 1. Qual è l'itinerario tipo che un ricercatore sociale segue nella realizzazione di una ricerca quantitativa? |
| 2. Che rapporto c'è tra teoria e ricerca nella ricerca quantitativa? |
| 3. In che cosa si differenziano i termini "concetto" e "variabile"? |
| 4. Che cosa significa il termine "operativizzare"? |
| 5. Nell'affermazione '[...]', quali sono le variabili indipendenti? |
| 6. Qual è la differenza fra variabili latenti e variabili osservate? |
| 7. Elencare e descrivere i differenti tipi o livelli di misurazione che possono caratterizzare una variabile. |
| 8. Quale requisito logico hanno in comune le procedure di classificazione, misurazione e conteggio? |
| 9. Che tipo di variabile è la variabile '[...]'? |
| 10. Che tipo di variabile è la variabile '[...]'? |
| 11. Qual è la funzione di un indicatore? |
| 12. In che cosa si differenziano i termini "indicatore" e "indice"? |
| 13. Illustrare e descrivere i concetti di validità e attendibilità degli strumenti di misura. |
| 14. In che cosa consiste la tecnica del test-retest? |
| 15. In che ambito specifico vengono impiegate e in che cosa consistono la procedura di validità per criterio e quella di costrutto? |
| Capitolo 4 (Causalità ed esperimento) - Corbetta+A80 | Mrs & Mqq |
| 1. Quale tipo di enunciato esprime compiutamente il nesso teorico di causa-effetto? |
| 2. Che cosa esprime l'enunciato "Se C, allora (e soltanto allora) E sempre”? |
| 3. Quando si può dire che una relazione è empiricamente corroborata? |
| 4. Quali elementi sono necessari e sufficienti per corroborare empiricamente una ipotesi causale? |
| 5. Che cosa si intende con il termine "covariazione" (fra due variabili X e Y)? |
| 6. Qual è il problema fondamentale dell’inferenza causale? |
| 7. In che cosa consiste la soluzione scientifica al problema fondamentale dell'inferenza causale? |
| 8. In che cosa consiste la soluzione statistica al problema fondamentale dell'inferenza causale? |
| 9. L'esperimento nelle scienze sociali è diverso rispetto a quello delle scienze naturali relativamente agli assunti di invarianza ed equivalenza? |
| 10. Che cosa si intende con l’espressione "gruppo di controllo" in ambito sperimentale? |
| 11. Quali sono gli elementi principali che distinguono l'esperimento dalle altre tecniche di indagine? |
| 12. A che cosa si riferisce il termine "casualizzazione" nell'ambito degli esperimento delle scienze sociali? |
| 13. Le tecniche di assegnazione dei soggetti ai gruppi di controllo in ambito sperimentale. |
| 14. Qual è la differenza fra veri-esperimenti e quasi-esperimenti? |
| 15. Che cosa sono i disegni sperimentali di tipo fattoriale e quali problemi di ricerca intendono risolvere? |
| 16. Che cosa si intende per disegno sperimentale "a serie temporale interrotta"? |
| Capitolo 5 (L'inchiesta campionaria) - Corbetta | Mrs & Mqq |
| 1. Quali elementi caratterizzano una matrice dei dati? |
| 2. Quali strumenti di rilevazione danno luogo alla matrice dei dati? |
| 3. Che cos'è un inchiesta campionaria? |
| 4. Quali elementi caratterizzano l'inchiesta campionaria? |
| 5. In che cosa si differenziano inchiesta campionaria e sondaggio? |
| 6. Quali sono le caratteristiche principali dell'intervista qualitativa? |
| 7. Quali sono le caratteristiche principali dell'intervista strutturata? |
| 8. Che cosa sostiene la posizione "costruttivista"? |
| 9. In che cosa consiste il problema dell'acquiescenza dell'intervistato? |
| 10. In che cosa consiste il problema del "response set"? |
| 11. In che cosa consiste il problema dell'effetto memoria nell'indagine campionaria? |
| 12. In che cosa consiste la tecnica cosiddetta dell'imbuto? |
| 13. Che cos'è una batteria di domande? |
| 14. Si supponga di dover stimare [...] ricorrendo ad una indagine campionaria. Quale strumento di raccolta dei dati è più opportuno adottare e perché? |
| 15. E' stata costruita una scheda di rilevazione per studiare [...]. Quale strumento di raccolta dei dati è più opportuno adottare e perché? |
| 16. Qual è la funzione del pretest nell'inchiesta campionaria? |
| 17. Che cos'è una inchiesta trasversale replicata? |
| Capitolo 7 (Le fonti statistiche ufficiali) - Corbetta | Mqq |
| 1. I diversi tipi e usi dei dati provenienti da statistiche ufficiali. |
| 2. I vantaggi delle rilevazioni campionarie rispetto a quelle censuarie nelle statistiche ufficiali. |
| 3. Caratteristiche delle rilevazioni dirette e indirette nell'ambito delle statistiche ufficiali. |
| 4. Collettivi, dati aggregati e dati individuali nelle statistiche ufficiali. |
| 5. Che cos'è l'analisi dei dati aggregati (aggregate data analysis). |
| 6. Le differenze tra le indagini campionarie e le statistiche ufficiali. |
| Capitolo 8 (Il campionamento) - Corbetta | Mrs & Mqq |
| 1. Che cosa indica l'espressione "errore di selezione"? |
| 2. Se calcoliamo la media di una variabile in un campione, che tipo di grandezza otteniamo? |
| 3. Da quali tipi di errore possono essere affette le stime ottenute da una indagine campionaria? |
| 4. Come si misura l'eterogeneità della percentuale di maschi in un campione? |
| 5. Quando non si deve considerare il fattore (1-f) nel calcolo dell'errore di campionamento? |
| 6. Da quali grandezze dipende l'errore di campionamento di una stima? |
| 7. Illustrare il concetto di "intervallo di fiducia" di una stima. |
| 8. Che cosa si intende con l'espressione "grandezza ottimale del campione"? |
| 9. Che cosa sono il campione stratificato proporzionale e quello non proporzionale? |
| 10. Che cos'è il campione stratificato ottimale? |
| 11. La tecnica del campionamento sistematico può essere impiegata nella costruzione di un campione stratificato e di un campione a stadi (a grappoli)? |
| 12. Quando non è disponibile la lista degli elementi di campionamento costituenti la popolazione di riferimento, si può ugualmente ricorrere al campionamento probabilistico? |
| 13. Per quali motivi si ricorre al campionamento a stadi? |
| 14. Che cos'è un campione a grappoli? |
| 15. Quale o quali tecniche di campionamento sono più efficienti del campione casuale semplice? |
| 16. Quali sono i fattori principali che influiscono sulla decisione circa la numerosità (grandezza) ottimale di un campione casuale semplice. |
| 17. In quali situazioni si deve ricorrere ad un campionamento non probabilistico? |
| 18. In che cosa si differenziano campione stratificato e campione per quote? |
| 19. Che cos'è un campionamento a disegno fattoriale? |
| 20. Nell'ambito dell'inchiesta telefonica che cos'è la tecnica RDD (random digit dialing)? |
| 21. Che cosa si intende con l'espressione "ponderazione di un campione" e in quali situazioni è necessario ricorrere a questa metodica? |
| 22. Si consideri una popolazione formata da [...] unità. e così distribuita: [...] adulti, [...] anziani, [...] giovani. Se l'età è una variabile rilevante per l'indagine e se l'ampiezza del campione deve essere pari a [...] unità, quale tipo di campionamento [...] ? |
| 23. Da una popolazione di [...] individui formata dal [...] di ebrei e dal [...] di cattolici è stato estratto un campione stratificato non proporzionale di [...] unità in cui [...] sono ebrei e [...] cattolici. Perché si è proceduto in questo modo? Occorre [...] ponderare il campione [...] ? |
| 24. Si deve stimare l'altezza media di due popolazioni di [...] soggetti. Sapendo che lo scarto quadratico medio dell'altezza nelle due popolazioni è rispettivamente pari a [...] cm. e a [...] cm. e che il primo campione è di [...] unità, quanto deve essere grande il secondo campione [...] ? |
| Capitolo 9 (L'osservazione partecipante) - Corbetta | Mqq |
| 1. L'analisi dei dati empirici nell'osservazione partecipante: aspetti operativi e modi dell'analisi. |
| 2. Su che cosa deve dirigere l'attenzione l'osservatore partecipante? |
| 3. Qual è il grado ottimale di coinvolgimento del ricercatore nel caso dell'osservazione partecipante? |
| 4. L'analisi dei dati empirici nell'osservazione partecipante in quanto processo e i suoi obiettivi. |
| 5. La specificità dell'osservazione partecipante rispetto alle altre strategie di raccolta dati. |
| 6. Il ruolo del mediatore culturale nell'osservazione partecipante. |
| 7. Limiti e risorse dell'osservazione partecipante. |
| 8. Elencare e descrivere sinteticamente gli ambiti di applicazione dell'osservazione partecipante. |
| 9. Che cos'è l'osservazione partecipante? |
| 10. Modalità e principi di registrazione dei dati nell'osservazione partecipante. |
| 11. La scelta tra osservazione partecipante dissimulata e palese anche con riguardo all'accesso al campo d'indagine. |
| 12. Caratteristiche principali dello studio sul campo (field-study). |
| Capitolo 10 (L'intervista qualitativa) - Corbetta | Mqq |
| 1. Che cos'è un’intervista qualitativa strutturata? Quando e perché si ricorre a questa metodica? |
| 2. Tecniche di campionamento nelle indagini basate su interviste qualitative. |
| 3. Quali differenze di struttura, obiettivo e risultati vi sono tra intervista qualitativa e quantitativa? |
| 4. Che cos'è un'intervista qualitativa semistrutturata? Quando e perché si ricorre a questa metodica? |
| 5. Ruolo dell'intervista qualitativa nei contesti della scoperta e della giustificazione. |
| 6. Il focus group come intervista qualitativa. Che cos'è, come si conduce, come si scelgono i partecipanti, quali risultati si ottengono? |
| 7. Perché e in che modo si utilizzano le domande-sonda nell'intervista qualitativa? |
| 8. Che cos'è un'intervista qualitativa non strutturata? Quando e perché si ricorre a questa metodica? |
| 9. Indicare tutti i tipi di interviste qualitative e, sinteticamente, gli aspetti che li differenziano. |
| 10. La mancanza di standardizzazione è un punto di forza o di debolezza dell'intervista qualitativa? Motivare la risposta. |
| 11. Quali sono i principali fattori che influenzano una corretta conduzione delle interviste qualitative? |
| 12. Differenze nell'analisi dei dati ottenuti da interviste qualitative e quantitative. |
| Capitolo 11 (L'uso dei documenti) - Corbetta | Mqq |
| 1. Che cosa sono e che ruolo hanno i documenti nella ricerca sociale. |
| 2. Elencare e descrivere brevemente i differenti tipi di documenti utilizzabili nella ricerca sociale. |
| 3. I differenti tipi di fonti documentarie istituzionali. Elencare e descrivere brevemente. |
| 4. Vantaggi e svantaggi della documentazione scritta rispetto alle altre metodiche di raccolta dati (es.: survey). |
| 5. I vantaggi e gli svantaggi dei documenti orali rispetto ai documenti scritti. |
| 6. Descrivere i differenti tipi di documenti orali e le loro specifiche caratteristiche. |
| Capitolo 12 (L'analisi monovariata) - Corbetta | Mrs & Mqq |
| 1. A che cosa serve lo strumento della matrice dati? |
| 2. In che cosa consiste l'operazione di codifica dei dati empirici raccolti? |
| 3. Che cos'è la distribuzione semplice di frequenze e quali dati può contenere? |
| 4. Che cos'è una distribuzione cumulata di frequenze? |
| 5. Perché nella percentualizzazione di una distribuzione di frequenza si utilizza l'arrotondamento (per eccesso e per difetto)? |
| 6. In quale contesto si può incontrare il problema della "quadratura" dei dati? |
| 7. Che cos'è la mediana e come si ricava? |
| 8. Che cosa sono i "valori di posizione"? |
| 9. In base a quali criteri si preferisce la mediana alla media o viceversa come misura di tendenza centrale che meglio rappresenta una data distribuzione di valori? |
| 10. La capacità informativa delle misure di tendenza centrale e di variabilità. |
| 11. Le misure di variabilità o di dispersione: quali sono? Che cosa misurano? quali requisiti devono sussistere perché si possano applicare? |
| 12. Quando si usa il campo di variazione? |
| 13. Quando si usano gli indici di omogeneità/eterogeneità. |
| 14. Che cosa sono la varianza e lo scarto quadratico medio e in che cosa si differenziano? |
| 15. Che cosa sono il coefficiente di variazione e lo scarto quadratico medio? |
| 16. Quando si usa il rapporto di concentrazione di Gini? |
| 17. In che cosa consiste la procedura di "standardizzazione di una variabile"? |
| 18. Quali sono gli scopi delle procedure di normalizzazione di una variabile? |
| 19. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di composizione? |
| 20. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di coesistenza? |
| 21. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di derivazione? |
| 22. Che cosa sono i "numeri indice"? In quale contesto trovano applicazione? Come si calcolano? |
| 23. Quali rappresentazioni grafiche si possono dare delle serie storiche? |
| 24. A cosa serve un cartogramma? |
| Capitolo 13 (L'analisi bivariata) - Corbetta | Mrs & Mqq |
| 1. Che cosa si intende con l'espressione "esiste covariazione tra i valori di due variabili'? |
| 2. Che cosa si intende con l'espressione "dimensione di una tavola"? |
| 3. In quali situazioni è necessario percentualizzare una tabella a doppia entrata? |
| 4. In una tavola di contingenza che contiene valori percentuali si possono effettuare operazioni di somma o sottrazione tra le singole celle della tavola? |
| 5. Quando si dice che una relazione è monotonica? |
| 6. In che cosa consiste un test statistico di verifica delle ipotesi come chi-quadrato? |
| 7. Cosa si intende con l'espressione "livello di probabilità del chi-quadrato" in rapporto alla sua distribuzione dei valori? |
| 8. Perché il test del chi-quadrato non è una soddisfacente misura di associazione? |
| 9. Che cosa sono i "gradi di libertà" del chi-quadrato? |
| 10. Con quali strumenti statistici si studia l'intensità di una relazione bivariata? |
| 11. Quali sono e che cosa misurano le misure di associazione? |
| 12. Quali misure di intensità della relazione sono asimmetriche? |
| 13. Quali valori può assumere l'indice statistico "phi"? |
| 14. In quale situazione si può utilizzare l'indice statistico V di Cramer? |
| 15. Da quali altre grandezze dipende il valore della misura di intensità della relazione "gamma"? |
| 16. I concetti di coppia concordante e di coppia discordante relativamente a tabelle a doppia entrata. |
| 17. Quando si dice che una relazione tra due variabili è spuria? |
| 18. Quando si dice che una relazione tra due variabili è indiretta? |
| 19. Che cos'è una relazione condizionata tra due variabili? |
| 20. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y e di aver ottenuto le seguenti 7 coppie di valori: [...] Descrivere la relazione tra le due variabili. |
| 21. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y e di aver ottenuto le seguenti 7 coppie di valori: [...] Descrivere la relazione tra le due variabili. |
| 22. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y e di aver ottenuto le seguenti 7 coppie di valori: [...] Descrivere la relazione tra le due variabili. |
| 23. Come si calcolano le frequenze attese richieste dal chi-quadrato? |
| 24. Il chi-quadrato ha un valore massimo? Se sì, qual è e in quali misure statistiche viene utilizzato? |
| teoria, ricerca, causalità, esperimento, inchiesta | Mrs (8Cfu) |
| 1. Come devono essere i risultati nella ricerca quantitativa? |
| 2. Che rapporto c'è tra teoria e ricerca nella ricerca quantitativa? |
| 3. Elencare e descrivere i differenti tipi o livelli di misurazione che possono caratterizzare una variabile. |
| 4. Quale requisito logico hanno in comune le procedure di classificazione, misurazione e conteggio? |
| 5. In che cosa si differenziano i termini 'indicatore' e 'indice'? |
| 6. Che tipo di variabile è la variabile ' [....]'? |
| 7. Che tipo di variabile è la variabile ' [....]'? |
| 8. Che cosa indica l'espressione "errore di rilevazione"? |
| 9. Illustrare e descrivere i concetti di validità e attendibilità degli strumenti di misura. |
| 10. In che cosa consiste la tecnica del test-retest? |
| 11. In che ambito specifico vengono impiegate e in che cosa consistono la procedura di validità per criterio e quella di costrutto? |
| 12. Che cosa esprime l'enunciato "Se C, allora (e soltanto allora) E sempre"? |
| 13. Significato di "relazione causale |
| 14. Quando si può dire che una relazione è empiricamente corroborata? |
| 15. Quali elementi sono necessari e sufficienti per corroborare empiricamente una ipotesi causale? |
| 16. Che cosa si intende con il termine "covariazione" (fra due variabili X e Y)? |
| 17. In che cosa consiste la soluzione statistica al problema fondamentale dell'inferenza causale? |
| 18. Quali sono gli elementi principali che distinguono l'esperimento dalle altre tecniche di indagine? |
| 19. Le tecniche di assegnazione dei soggetti ai gruppi di controllo in ambito sperimentale. |
| 20. Che cosa sono i disegni sperimentali di tipo fattoriale e quali problemi di ricerca intendono risolvere? |
| 21. Quali strumenti di rilevazione danno luogo alla matrice dei dati? |
| 22. Che cos'è un inchiesta campionaria? |
| 23. Quali elementi caratterizzano l'inchiesta campionaria? |
| 24. In che cosa si differenziano inchiesta campionaria e sondaggio? |
| 25. Quali sono le caratteristiche principali dell'intervista qualitativa? |
| 26. Quali sono le caratteristiche principali dell'intervista strutturata? |
| 27. In che cosa consiste il problema dell'acquiescenza dell'intervistato? |
| 28. In che cosa consiste il problema del 'response set'? |
| 29. In che cosa consiste il problema dell'effetto memoria nell'indagine campionaria? |
| 30. Differenze tra domande aperte e chiuse |
| 31. Si supponga di dover stimare [....] ricorrendo ad una indagine campionaria. Quale strumento di raccolta dei dati è più opportuno adottare e perché? |
| 32. Che cosa si intende con "intervista telefonica"? |
| 33. E' stata costruita una scheda di rilevazione per studiare [....]. Quale strumento di raccolta dei dati è più opportuno adottare e perché? |
| 34. Qual è la funzione del pretest nell'inchiesta campionaria? |
| 35. Strumenti di rilevazione e tassi di copertura |
| 36. Che cos'è una inchiesta trasversale replicata? |

| campionamento | Mrs (8Cfu) |
| 1. Che cosa indica l'espressione "errore di selezione"? |
| 2. Quale o quali tra questi errori non riguardano la fase del campionamento. |
| 3. Se calcoliamo la media di una variabile in un campione, che tipo di grandezza otteniamo? |
| 4. Come si misura l'eterogeneità della percentuale di maschi in un campione? |
| 5. Quando non si deve considerare il fattore (1-f) nel calcolo dell'errore di campionamento? |
| 6. Da quali grandezze dipende l'errore di campionamento di una stima? |
| 7. Che cos'è "l'intervallo di fiducia" di una stima? |
| 8. Che cosa si intende con l'espressione "grandezza ottimale del campione"? |
| 9. Sia [...] l'errore che caratterizza la stima ottenuta con un campione di ampiezza [...]. Quale deve essere l'ampiezza [...]? |
| 10. Sia [...] l'errore di campionamento al livello di fiducia del [...]. Per [...] l'errore [...] cosa occorre fare? |
| 11. Si deve stimare l'altezza media di due popolazioni di [.] soggetti. Sapendo che lo scarto quadratico medio dell'altezza nelle due popolazioni è rispettivamente pari a [.] cm. e a [.] cm. e che il primo campione è di [.] unità, quanto deve essere grand |
| 12. Quali sono i fattori principali che influiscono sulla decisione circa la numerosità ottimale di un campione casuale semplice? |
| 13. Quale o quali tecniche di campionamento sono più efficienti del campione casuale semplice? |
| 14. In quali situazioni si deve ricorrere ad un campionamento non probabilistico? |
| 15. Che cosa si intende con l'espressione "ponderazione di un campione" e in quali situazioni è necessario ricorrere a questa metodica? |
| 16. Che cosa sono il campione stratificato proporzionale e non proporzionale e in che cosa differiscono? |
| 17. Che cos'è il campione stratificato ottimale? |
| 18. Si consideri una popolazione formata da [.] unità. e così distribuita: [.] adulti, [.] anziani, [.] giovani. Se l'età è una variabile rilevante per l'indagine e se l'ampiezza del campione deve essere pari a [.] unità, quale tipo di campionamento [...] |
| 19. Da una popolazione di [.] individui formata da [.] ebrei e da [.] cattolici è stato estratto un campione stratificato non proporzionale di [.] unità in cui [.] sono ebrei e [.] cattolici. Perché si è proceduto in questo modo? Occorre [...] ponderare |
| 20. In che cosa si differenziano campione stratificato e campione per quote? |
| 21. Quale o quali procedure di campionamento possono essere utilizzate nella costruzione di un campionamento stratificato? |
| 22. Per quali motivi si ricorre al campionamento a stadi? |
| 23. Che cos'è un campione a grappoli? |
| 24. Quale o quali procedure di campionamento possono essere utilizzate nella costruzione di un campionamento a stadi? |

| analisi monovariata | Mrs (8Cfu) |
| 1. A che cosa serve lo strumento della matrice dati? |
| 2. Quali elementi caratterizzano una matrice dei dati? |
| 3. In che cosa consiste l'operazione di codifica dei dati empirici raccolti? |
| 4. Quando si può utilizzare l'indice di omogeneità? |
| 5. Perché nella percentualizzazione di una distribuzione di frequenza si utilizza l'arrotondamento (per eccesso e per difetto)? |
| 6. In quale contesto si può incontrare il problema della "quadratura" dei dati? |
| 7. Che cosa sono i "valori di posizione"? |
| 8. In base a quali criteri si preferisce la mediana alla media o viceversa come misura di tendenza centrale che meglio rappresenta una data distribuzione di valori? |
| 9. Le misure di variabilità o di dispersione: quali sono? Che cosa misurano? quali requisiti devono sussistere perché si possano applicare? |
| 10. Quando si usa il campo di variazione? |
| 11. Quando si usano gli indici di omogeneità/eterogeneità? |
| 12. Quando si può utilizzare la differenza interquartile? |
| 13. Che cosa sono la varianza e lo scarto quadratico medio e in che cosa si differenziano? |
| 14. Che cosa sono il coefficiente di variazione e lo scarto quadratico medio? |
| 15. Quando si usa il rapporto di concentrazione di Gini? |
| 16. In che cosa consiste la procedura di "standardizzazione di una variabile"? |
| 17. Quali sono gli scopi delle procedure di normalizzazione di una variabile? |
| 18. Che cosa sono i "numeri indice"? |
| 19. A cosa serve un cartogramma? |
| 20. Quali rappresentazioni grafiche si possono dare delle serie storiche? |
| 21. In un istogramma a che grandezza è proporzionale la frequenza dei casi appartenenti ad una categoria? |
| 22. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di composizione? |
| 23. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di coesistenza? |
| 24. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di derivazione? |

| analisi bivariata | Mrs (8Cfu) |
| 1. In quali situazioni è necessario percentualizzare una tabella a doppia entrata? |
| 2. In una tavola di contingenza che contiene valori percentuali si possono effettuare operazioni di somma o sottrazione tra le singole celle della tavola? |
| 3. Nella tabella bivariata 2 x 2 riportata a lato, [...], quanti casi deve contenere la casella [...] perché non [...]? |
| 4. Nella tabella bivariata 2 x 2 riportata a lato, [...], quanti casi deve contenere la casella [...] perché [...]? |
| 5. Nella tabella bivariata 2 x 2 riportata a lato, [...], quanti casi deve contenere la casella [...] perché [...]? |
| 6. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y e di aver ottenuto le seguenti 7 coppie di valori: [.] Che relazione c'è? |
| 7. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y [.]. Che relazione c'è? |
| 8. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y [.]. Che relazione c'è? |
| 9. In che cosa consiste un test statistico di verifica delle ipotesi come chi-quadrato ? |
| 10. Cosa si intende con l'espressione "livello di probabilità del chi-quadrato" in rapporto alla sua distribuzione dei valori? |
| 11. Perché il test del chi-quadrato non è una soddisfacente misura di associazione? |
| 12. Che cosa sono i "gradi di libertà" del chi-quadrato? |
| 13. Come si calcolano le frequenze attese richieste dal chi-quadrato? |
| 14. Il chi-quadrato ha un valore massimo? Se sì, qual è e in quali misure statistiche viene utilizzato? |
| 15. Se in una tabella 4 x 2 con totale [...] il valore di chi-quadrato [...],che cosa si può sostenere? |
| 16. Se in una tabella 4 x 2 il valore di chi-quadrato [...], che cosa si può sostenere? |
| 17. Con quali strumenti statistici si studia l'intensità di una relazione bivariata? |
| 18. Quali sono e che cosa misurano le misure di associazione? |
| 19. Quali valori può assumere l'indice statistico "phi"? |
| 20. In quale situazione si può utilizzare l'indice statistico V di Cramer? |
| 21. Da quali grandezze dipende il valore della misura di intensità della relazione "gamma"? |
| 22. I concetti di coppia concordante e di coppia discordante relativamente a tabelle a doppia entrata. |
| 23. Se in una tabella 3 x 3 il valore di [...] qual è il valore di chi-quadrato? |
| 24. Se in una tabella 5 x 5 il valore di [...] qual è il valore di chi-quadrato? |
| 25. Se in una tabella il valore dell'indice di cograduazione [...], qual è il corrispondente valore di [...]? |
| 26. Se in una tabella il valore dell'indice di cograduazione [...], qual è il corrispondente valore di [...]? |
| 27. Se in una tabella il numero di coppie concordanti è [...], qual è il valore di gamma? |
| 28. Se in una tabella il numero di coppie concordanti è [...], qual è il valore di gamma? |
| 29. Che cos'è l'analisi della varianza? |
| 30. Che cosa afferma il teorema fondamentale della varianza? |
| 31. Si supponga che il valore del coefficiente di correlazione tra le due variabili X e Y sia risultato [...]. Quanta varianza di [...]? |
| 32. Si supponga che il valore del coefficiente di correlazione tra le due variabili X e Y sia risultato [...]. Quanta varianza di [...]? |
| 33. Se tra due variabili cardinali c'è una [...] relazione [...], qual è il valore del coefficiente di correlazione ? |
| 34. Se in un diagramma di dispersione [...] qual è il valore del coefficiente di correlazione? |
| 35. L'equazione di regressione che meglio descrive la relazione tra due variabili è [...]. Che cosa si può dire della retta e della relazione? |
| 36. Che cosa sono regressione e correlazione? |
| 37. L'equazione di regressione che meglio descrive la relazione tra due variabili è [...]. Che cosa si può dire della retta e della relazione? |
| 38. Una retta di regressione passa dai punti [...]. [...], qual è il valore del coefficiente b? |
| 39. Una retta di regressione passa dai punti [...]. [...], qual è il valore del coefficiente a? |
| 40. Il diagramma di dispersione a destra [...]. La retta interpolante tracciata con il metodo dei minimi quadrati che cosa indicherebbe? |
| 41. Il diagramma di dispersione a destra [...]. La retta interpolante tracciata con il metodo dei minimi quadrati che cosa indicherebbe? |
| 42. Il diagramma di dispersione a destra [...]. La retta interpolante tracciata con il metodo dei minimi quadrati che cosa indicherebbe? |
| 43. Che cosa misura il coefficiente di correlazione |
| 44. Quando si dice che una relazione tra due variabili è spuria? |
| 45. Quando si dice che una relazione tra due variabili è indiretta? |
| 46. Che cos'è una relazione condizionata tra due variabili? |
| 47. Se [...] rappresenta lo schema dei legami causali tra tre variabili e se c'è covariazione tra [...], indicare il tipo di relazione che intercorre [...]. |
| 48. Se [...] rappresenta lo schema dei legami causali tra tre variabili e se c'è covariazione tra [...], indicare il tipo di relazione che intercorre [...]. |

| sul campionamento | Statistica sociale |
| 1. Che cosa indica l'espressione 'errore di selezione'? |
| 2. Quale o quali tra questi errori non riguardano la fase del campionamento. |
| 3. Se calcoliamo la media di una variabile in un campione, che tipo di grandezza otteniamo? |
| 4. Come si misura l'eterogeneità della percentuale di maschi in un campione? |
| 5. Quando non si deve considerare il fattore (1-f) nel calcolo dell'errore di campionamento? |
| 6. Da quali grandezze dipende l'errore di campionamento di una stima? |
| 7. Che cos'è "l'intervallo di fiducia" di una stima? |
| 8. Che cosa si intende con l'espressione "grandezza ottimale del campione"? |
| 9. Sia [...] l'errore che caratterizza la stima ottenuta con un campione di ampiezza [...]. Quale deve essere l'ampiezza [...]? |
| 10. Sia [...] l'errore di campionamento al livello di fiducia del [...]. Per [...] l'errore [...] cosa occorre fare? |
| 11. Si deve stimare l'altezza media di due popolazioni di [...] soggetti. Sapendo che lo scarto quadratico medio dell'altezza nelle due popolazioni è rispettivamente pari a [...] cm. e a [...] cm. e che il primo campione è di [...] unità, quanto deve essere grande [...] ? |
| 12. Quali sono i fattori principali che influiscono sulla decisione circa la numerosità ottimale di un campione casuale semplice? |
| 13. Quando non è disponibile la lista degli elementi di campionamento costituenti la popolazione di riferimento, si può ugualmente ricorrere al campionamento probabilistico? |
| 14. Quale o quali tecniche di campionamento sono più efficienti del campione casuale semplice? |
| 15. In quali situazioni si deve ricorrere ad un campionamento non probabilistico? |
| 16. Che cosa si intende con l'espressione "ponderazione di un campione" e in quali situazioni è necessario ricorrere a questa metodica? |
| 17. Che cosa sono il campione stratificato proporzionale e non proporzionale e in che cosa differiscono? |
| 18. Che cos'è il campione stratificato ottimale? |
| 19. Si consideri una popolazione formata da [...] unità. e così distribuita: [...] adulti, [...] anziani, [...] giovani. Se l'età è una variabile rilevante per l'indagine e se l'ampiezza del campione deve essere pari a [...] unità, quale tipo di campionamento [...] ? |
| 20. Da una popolazione di [...] individui formata da [...] ebrei e da [...] cattolici è stato estratto un campione stratificato non proporzionale di [...] unità in cui [...] sono ebrei e [...] cattolici. Perché si è proceduto in questo modo? Occorre [...] ponderare il campione [...] ? |
| 21. In che cosa si differenziano campione stratificato e campione per quote? |
| 22. Quale o quali procedure di campionamento possono essere utilizzate nella costruzione di un campionamento stratificato? |
| 23. Per quali motivi si ricorre al campionamento a stadi? |
| 24. Che cos'è un campione a grappoli? |
| 25. Quale o quali procedure di campionamento possono essere utilizzate nella costruzione di un campionamento a stadi? |
| 26. Le principali procedure di ponderazione del campione: differenze e limiti. |
| sull’analisi monovariata | Statistica sociale |
| 1. A che cosa serve lo strumento della matrice dati? |
| 2. Quali elementi caratterizzano una matrice dei dati? |
| 3. In che cosa consiste l'operazione di codifica dei dati empirici raccolti? |
| 4. Che tipo di variabile è la variabile '[...]'? |
| 5. Perché nella percentualizzazione di una distribuzione di frequenza si utilizza l'arrotondamento (per eccesso e per difetto)? |
| 6. In quale contesto si può incontrare il problema della "quadratura" dei dati? |
| 7. Che cos'è la mediana e come si ricava? |
| 8. Che cosa sono i "valori di posizione"? |
| 9. In base a quali criteri si preferisce la mediana alla media o viceversa come misura di tendenza centrale che meglio rappresenta una data distribuzione di valori? |
| 10. Le misure di variabilità o di dispersione: quali sono? Che cosa misurano? quali requisiti devono sussistere perché si possano applicare? |
| 11. Quando si usa il campo di variazione? |
| 12. Quando si usano gli indici di omogeneità/eterogeneità? |
| 13. Quando si può utilizzare la differenza interquartile? |
| 14. Che cosa sono la varianza e lo scarto quadratico medio e in che cosa si differenziano? |
| 15. Che cosa sono il coefficiente di variazione e lo scarto quadratico medio? |
| 16. Quando si usa il rapporto di concentrazione di Gini? |
| 17. La capacità informativa delle misure di tendenza centrale e di variabilità. |
| 18. In che cosa consiste la procedura di "standardizzazione di una variabile"? |
| 19. Quali sono gli scopi delle procedure di normalizzazione di una variabile? |
| 20. Che cosa sono i "numeri indice"? |
| 21. A cosa serve un cartogramma? |
| 22. Quali rappresentazioni grafiche si possono dare delle serie storiche? |
| 23. In un istogramma a che grandezza è proporzionale la frequenza dei casi appartenenti ad una categoria? |
| 24. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di composizione? |
| 25. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di coesistenza? |
| 26. Che cosa si confronta attraverso i rapporti di derivazione? |
| sull'analisi bivariata | Statistica sociale |
| 1. In quali situazioni è necessario percentualizzare una tabella a doppia entrata? |
| 2. Nella tabella bivariata 2 x 2 riportata a lato, [...], quanti casi deve contenere la casella [...] perché non [...] ? |
| 3. Nella tabella bivariata 2 x 2 riportata a lato, [...], quanti casi deve contenere la casella [...] perché [...] ? |
| 4. Nella tabella bivariata 2 x 2 riportata a lato, [...], quanti casi deve contenere la casella [...] perché [...] ? |
| 5. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y [...]. Che relazione c'è? |
| 6. Si supponga di aver misurato la posizione di 7 soggetti su due generiche variabili ad intervalli X e Y [..]. Che relazione c'è? |
| 7. In che cosa consiste un test statistico di verifica delle ipotesi come chi-quadrato? |
| 8. Cosa si intende con l'espressione "livello di probabilità del chi-quadrato" in rapporto alla sua distribuzione dei valori? |
| 9. Perché il test del chi-quadrato non è una soddisfacente misura di associazione? |
| 10. Che cosa sono i "gradi di libertà" del chi-quadrato? |
| 11. Come si calcolano le frequenze attese richieste dal chi-quadrato? |
| 12. Il chi-quadrato ha un valore massimo? Se sì, qual è e in quali misure statistiche viene utilizzato? |
| 13. Se in una tabella 4 x 2 con totale [...] il valore di chi-quadrato [...],che cosa si può sostenere? |
| 14. Se in una tabella 4 x 2 il valore di chi-quadrato [...], che cosa si può sostenere? |
| 15. Con quali strumenti statistici si studia l'intensità di una relazione bivariata? |
| 16. Quali sono e che cosa misurano le misure di associazione? |
| 17. Quali valori può assumere l'indice statistico "phi"? |
| 18. In quale situazione si può utilizzare l'indice statistico V di Cramer? |
| 19. Da quali grandezze dipende il valore della misura di intensità della relazione "gamma"? |
| 20. I concetti di coppia concordante e di coppia discordante relativamente a tabelle a doppia entrata. |
| 21. Se in una tabella 3 x 3 il valore di [...] qual è il valore di chi-quadrato? |
| 22. Se in una tabella 5 x 5 il valore di [...] qual è il valore di chi-quadrato? |
| 23. Se in una tabella il valore dell'indice di cograduazione [...], qual è il corrispondente valore di [...] ? |
| 24. Se in una tabella il valore dell'indice di cograduazione [...], qual è il corrispondente valore di [...] ? |
| 25. Se in una tabella il numero di coppie concordanti è [...], qual è il valore di "gamma"? |
| 26. Se in una tabella il numero di coppie concordanti è [...], qual è il valore di "gamma"? |
| 27. Che cos'è l'analisi della varianza? |
| 28. Si supponga che il valore del coefficiente di correlazione tra le due variabili X e Y sia risultato [...]. Quanta varianza di [...] ? |
| 29. Si supponga che il valore del coefficiente di correlazione tra le due variabili X e Y sia risultato [...]. Quanta varianza di [...] ? |
| 30. Se tra due variabili cardinali c'è una [...] relazione [...], qual è il valore del coefficiente di correlazione? |
| 31. Se in un diagramma di dispersione [...] qual è il valore del coefficiente di correlazione? |
| 32. L'equazione di regressione che meglio descrive la relazione tra due variabili è [...]. Che cosa si può dire della retta e della relazione? |
| 33. Che cosa sono regressione e correlazione? |
| 34. L'equazione di regressione che meglio descrive la relazione tra due variabili è [...]. Che cosa si può dire della retta e della relazione? |
| 35. Una retta di regressione passa dai punti [...]. [...], qual è il valore del coefficiente b? |
| 36. Una retta di regressione passa dai punti [...]. [...], qual è il valore del coefficiente a? |
| 37. Il diagramma di dispersione a destra [...]. La retta interpolante tracciata con il metodo dei minimi quadrati che cosa indicherebbe? |
| 38. Il diagramma di dispersione a destra [...]. La retta interpolante tracciata con il metodo dei minimi quadrati che cosa indicherebbe? |
| 39. Quando si dice che una relazione tra due variabili è spuria? |
| 40. Quando si dice che una relazione tra due variabili è indiretta? |
| 41. Che cos'è una relazione condizionata tra due variabili? |
| 42. Se [...] rappresenta lo schema dei legami causali tra tre variabili e se c’è covariazione tra [...], indicare il tipo di relazione che intercorre [...]. |
| 43. Se [...] rappresenta lo schema dei legami causali tra tre variabili e se c’è covariazione tra [...], indicare il tipo di relazione che intercorre [...]. |
| 44. Se [...] rappresenta lo schema dei legami causali tra tre variabili e se c’è covariazione tra [...], indicare il tipo di relazione che intercorre [...]. |
| Besozzi | Soc. Educazione |
| 1. Legami individuo-società e rapporti educazione-società: i diversi modelli. |
| 2. Il rapporto educazione società secondo il modello classico (Durkheim, Weber, Marx). |
| 3. Tipi di potere, tipi di cultura e tipi educativi. |
| 4. La concezione conflittualista del rapporto educazione-società. |
| 5. Modelli di socializzazione: il modello funzionalista. |
| 6. Modelli di socializzazione: il modello conflittualista. |
| 7. Modelli di socializzazione: il modello interazionista. |
| 8. Modelli di socializzazione e costruzione dell’identità. |
| 9. Concezioni delle opportunità educative e funzioni dei sistemi scolastici. |
| 10. Teorie ed ipotesi sulla riuscita scolastica. |
| 11. Il fenomeno della dispersione scolastica: evoluzione, caratteristiche, cause, ecc. |
| 12. La famiglia: tipi e modelli, funzioni, processi di socializzazione. |
| 13. La scuola come istituzione, le sue 'culture' e le sue funzioni. |
| 14. Scolarità e sue trasformazioni nella realtà italiana. |
| 15. La scuola italiana e gli alunni stranieri. |
| 16. Ruolo professionale degli insegnanti e sue trasformazioni. |
| 17. Il gruppo dei pari come agenzia di socializzazione. |
| 18. L'impatto dei media sulla socializzazione e la costruzione di identità. |
| Schizzerotto-Baroni | Soc. Educazione |
| 1. Ipotesi e teorie sull'origine della scolarizzazione di massa. |
| 2. Le funzioni della scuola nella società contemporanea e loro evoluzione storica. |
| 3. Differenziazione verticale ed orizzontale dei sistemi scolastici: modelli nazionali e conseguenze sociali dei diversi modelli organizzativi. |
| 4. Standardizzazione e centralizzazione dei sistemi scolastici: modelli nazionali e conseguenze sociali dei diversi modelli organizzativi. |
| 5. L'effetto delle riforme scolastiche sulle dimensioni (assoluta/relativa, verticale/orizzontale) delle disuguaglianze di istruzione. |
| 6. Le disuguaglianze assolute e relative di istruzione, l'origine sociale e i tassi di scolarità: definizioni, correlazioni tra i fenomeni, andamenti temporali e loro interpretazioni. |
| 7. In che cosa consiste e che cosa spiega "l'ipotesi della selezione differenziale"? |
| 8. Elencare e descrivere le diverse teorie che tentano di spiegare le disuguaglianze di istruzione. |
| 9. Che cosa spiega la teoria della scelta (o azione razionale)? |
| 10. Disuguaglianze di istruzione 'verticali' e 'orizzontali' nel sistema scolastico italiano: definizioni, dimensioni, andamenti temporali. |
| 11. Istruzione e disuguaglianze di genere in Italia: dimensioni, andamenti temporali. |
| 12. Istruzione e disuguaglianze legate alla residenza e all'etnia in Italia: dimensioni, andamenti temporali. |
| 13. Le relazioni tra istruzione e mobilità sociale: teorie a confronto. |
| 14. L'influenza del grado di istruzione sul destino sociale degli individui. |
| 15. Istruzione, mobilità e meritocrazia in Italia. |
| 16. Valore dei titoli di studio e andamento dei tassi di scolarizzazione. |
| 17. Influenza del titolo di studio sulla modalità della presenza/assenza nel mercato del lavoro. |
| 18. Grado di istruzione e formazione delle famiglie in Italia. |
| 19. I compiti degli insegnanti e le valenze dell'insegnamento. |
| 20. Gli insegnanti italiani: caratteristiche sociali e loro effetti sul funzionamento della scuola. |
| 21. Le problematiche legate alla formazione, selezione e valutazione degli insegnanti in Italia. |
| 22. La percezione che gli insegnanti italiani hanno del proprio ruolo e dell'ambiente di lavoro. |
| 23. Modelli di curricula scolastici: evoluzione storica e ipotesi sulle cause dei mutamenti. |
| 24. Modelli di curricula scolastici ed effetti sui processi di apprendimento. |
| 25. La definizione del concetto di alfabetizzazione funzionale e le sue dimensioni. |
| 26. La variabilità, da paese a paese, dei livelli medi di apprendimento e le sue cause. |
| 27. L’interazione in classe e i processi di apprendimento. |
| Dei, La scuola...(ed. 2007) | Soc. Educazione |
| 1. Trama delle riforme della scuola e politica del cacciavite. |
| 2. Centralismo e autonomia nella scuola italiana. |
| 3. Scuola materna e scuola dell'infanzia in Italia ieri e oggi. |
| 4. La scuola primaria in Italia ieri e oggi. |
| 5. La scuola secondaria di primo grado in Italia ieri e oggi. |
| 6. La scuola secondaria di secondo grado in Italia ieri e oggi. |
| 7. Gli utenti della scuola: numerosità, genere, scelta degli indirizzi secondari, alunni immigrati, ecc. |
| 8. I docenti della scuola italiana: numerosità, composizione per genere ed età, reclutamento, qualità, ecc. |
| 9. Il funzionamento della scuola italiana: dimensioni ed evoluzione della dispersione scolastica. |
| 10. Il funzionamento della scuola italiana: i rendimenti dell'istruzione. |
| Brint | Soc. Educazione2 |
| 1. Le principali caratteristiche organizzative - positive e negative - dei sistemi scolastici in quanto sistemi educativi altamente formalizzati. |
| 2. Descrivere le strategie attraverso le quali le scuole tentanto di costituire un "ordine sociale" interno. |
| 3. I tre livelli dell'analisi sociologica dell'istruzione scolastica in una prospettiva comparata. |
| 4. Gli approcci teorici che descrivono il ruolo dei sistemi scolastici e il loro rapporto con il sistema sociale. |
| 5. I due principali punti di vista sul ruolo dell'istruzione pubblica, alla luce anche della crescita della domanda di istruzione nei paesi industrializzati nel corso del secolo XX. |
| 6. A quale sistema scolastico straniero assomiglia di più quello italiano? Rispetto a quale sistema presenta le maggiori differenze? Elencare e descrivere i principali punti di contatto o di divergenza. |
| 7. Quali fattori spiegano le diversità tra i sistemi scolastici nazionali alla luce degli approcci sistemico e comparato? |
| 8. Curricula e multiculturalismo: le differenti concezioni del concetto di multiculturalismo e le conseguenze sui curricula scolastici. |
| 9. I curricula scolastici nella loro evoluzione storica. Finalità e idealità che ne sono a fondamento e loro trasformazioni. |
| 10. Rendimento dei sistemi scolastici contemporanei nella trasmissione di conoscenze. Differenze nazionali e loro cause. |
| 11. Principali dimensioni della socializzazione e rapporto con la finalità socializzatrice dei sistemi scolastici. |
| 12. Tipi ideali di ambienti di socializzazione scolastica e loro evoluzione storica. |
| 13. Contenuti e pratiche della socializzazione in aula nella scuola contemporanea. |
| 14. Esperienze e contenuti nella socializzazione non scolastica. |
| 15. Cos'è la « società del credenzialismo »? |
| 16. Principali dimensioni della relazione tra origine sociale e riuscita scolastica. |
| 17. Principali dimensioni della relazione tra livello di istruzione e conseguimento di status. |
| 18. I principali fattori di disuguaglianza sociale e di opportunità educative in prospettiva storica. |
| 19. Il genere come fattore di disuguaglianza sociale e di opportunità educative in prospettiva storica. |
| 20. Distribuzione delle risorse sociali e stratificazione dei sistemi scolastici: loro effetti sulle disuguaglianze di fronte all'istruzione e strategie di adattamento dei diversi gruppi sociali. |

| Dei, La scuola... (ed. 2012) | Soc. Educazione2 |
| 1. La logica delle riforme della scuola italiano dal 2000. |
| 2. La scuola italiana: centralismo ed autonomia. |
| 3. Scuola materna e scuola dell'infanzia in Italia in prospettiva storica. |
| 4. La scuola primaria in Italia in prospettiva storica. |
| 5. La scuola secondaria di primo grado in Italia in prospettiva storica. |
| 6. La scuola secondaria di secondo grado in prospettiva storica. |
| 7. Gli studenti delle scuole superiori in Italia: quanti sono, chi sono, da dove vengono, cosa studiano. |
| 8. Gli insegnanti della scuola italiana: quanti sono, chi sono, cosa sanno fare, come vengono scelti e preparati. |
| 9. Il funzionamento della scuola italiana: dimensioni ed evoluzione della dispersione scolastica ai differenti livelli d'istruzione. |
| 10. Il funzionamento della scuola italiana: i rendimenti dell'istruzione e la loro eterogeneità. |

| Dei, Ragazzi si copia | Soc. Educazione2 |
| 1. Ontologia e fenomenologia del « copiare ». |
| 2. Pratica del « copiare »: la dimensione del fenomeno nella scuola media superiore e i principali fattori di variabilità. |
| 3. Sentimenti e rappresentazioni del « copiare » tra gli studenti delle scuole medie superiori. |
| 4. Valutazione etica e sociale della pratica del « copiare » tra gli studenti della media superiore. |
| 5. Pratica del « copiare »: la dimensione del fenomeno nell'ultimo anno della scuola elementare e nella scuola media inferiore e i principali fattori di variabilità. |
| 6. Sentimenti e rappresentazioni del « copiare » tra gli alunni dell'ultimo anno della scuola elementare e della scuola media inferiore . |
| 7. Valutazione etica e sociale della pratica del « copiare » tra gli alunni dell'ultimo anno della scuola elementare e della scuola media inferiore. |
| 8. Il comportamento degli insegnanti di fronte alla pratica del « copiare » nella percezione dei loro alunni. |
| 9. La prova Invalsi e la questione meridionale: fatti, interpretazioni, manipolazioni. |
| 10. La scuola italiana di fronte ai ragazzi che copiano: norme e comportamenti quotidiani. |


